Che alla gente delle nostre montagne piaccia bere, è cosa nota. È difficile identificare le cause di questo fenomeno sociale, ma possiamo almeno chiederci quanto sia radicato storicamente. Una risposta può essere ricavata da un esempio specifico: quello dell’Ampezzo dell’età moderna, dove – l’avreste mai detto? – la gente si ubriacava, spesso e volentieri, da sola e in compagnia, con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Come facciamo ad esserne sicuri? Ce lo dicono i documenti.
Facciamo un passo indietro: l’ubriachezza, come tutti sanno, può condurre a comportamenti disdicevoli, puniti tanto oggi quanto in passato come reati. Durante l’età moderna, in Ampezzo, il diritto penale era regolato dagli Statuti cadorini, che, come ricorderete dal post 178, erano stati mantenuti in vigore anche dopo l’aggregazione al Tirolo. In particolare, il Trattato secondo del Libro terzo degli Statuti punisce vari comportamenti spesso associati all’ubriachezza; possiamo ricordarne alcuni, con le parole delle rubriche che accompagnano le disposizioni: “Di quelli che bestemmiano Iddio, la Beata Vergine, o Santi” (Capitolo XIV), “Di quelli che dicono ingiurie, o parole ingiuriose ad alcuno” (Cap. XV), “Di quelli che percuotono un altro con bastone, o simil cosa nella faccia, o altrove con effusione di sangue, o senza, e di quello che morde un altro” (Cap. XIX), “Del cominciare la rissa in piazza, ovvero mercato, o fuori” (Cap. XXXII).

Il frontespizio dell'edizione del 1545 degli Statuti cadorini.
Naturalmente per accertare un reato è necessario istruire un processo, che all’epoca in Ampezzo era gestito dal cosiddetto “Ufficio criminale”, un tribunale composto dal capitano del Castello di Botestagno, in funzione di “vicario”, cioè giudice, e da quattro “consoli” locali che lo affiancavano. Di questa attività processuale restano molti documenti, che costituiscono la nostra fonte principale per approfondire le abitudini alcoliche degli ampezzani di quei secoli. È proprio grazie a loro che possiamo affermare che osterie, gioco e risse erano fenomeni ben noti alle persone.

Parte delle “Sibille”, affresco quattrocentesco che si ritiene ornasse la sala dove il Vicario giudicava le cause.
Le più antiche notizie giunte fino a noi risalgono al XVI secolo. Nel 1558 il governo di Innsbruck era evidentemente a conoscenza del problema, tanto da ordinare al vicecapitano di Botestagno Peter Mörl di eliminare «i peggiori vizi di Cortina e Acquabona [due dei villaggi ampezzani dove si trovavano frequentate osterie]: ubriachezza, gioco, orrende bestemmie contro Dio, sedere giocando e bevendo fino a notte fonda anche nelle case private» [1]. Il vicecapitano avrebbe dovuto usare il pugno duro per eliminare queste devianze, punendo severamente i malfattori.

Il Castello di Botestagno raffigurato da Matthias Burglechner in seguito al rifacimento del 1568.
L’ordine deve aver sortito scarso successo, se pochi anni dopo, nel 1579, il sanvitese Agostino de Matio viene condannato per aver detto a Giuliana Pompanin, incinta, passando per Zuel: «Te volemo brusar ti, con tuti li altri qua dentro, bruta todesca poltrona, el sango de la Vergine Maria!» [2]. Il de Matio si giustifica così: «ero embriago da vin e allora son peggio de na bestia, però domando misericordia» [3]. Vale la pena osservare che per andare da San Vito a Zuel il cadorino era molto probabilmente passato per Acquabona (e la sua osteria).
Il secolo che però ci ha lasciato più testimonianze è il XVII, periodo per il quale si sono conservati nell’archivio comunale gli atti di un centinaio di processi per reati minori (mentre i documenti per i delitti capitali, spediti ad Innsbruck, sono andati perduti). Di questi processi, quasi la metà hanno per oggetto colluttazioni e ferimenti sotto l’influsso del vino (43), seguiti dalle ingiurie (17) e infine da tutti gli altri reati.
A quanto emerge dai documenti, all’epoca gli ampezzani non disdegnavano trattenersi fino a tarda notte nelle osterie del paese (c’erano quelle di Acquabona e di Ospitale, oltre a quella di Cortina, chiamata “Alle due spade”, poi “Alla croce bianca”, affiancata forse da altre), specie in occasione di feste religiose e civili. Il vino e il gioco d’azzardo (morra, dadi, carte) scaldavano gli animi degli avventori, che diventavano facili all’ingiuria e alla bestemmia. Per ragioni di rispetto religioso quest’ultime non vengono riportate negli atti processuali, mentre ci è stato trasmesso qualche esempio di colorito insulto rivolto agli avversari: nel 1641 Jacomo de Cortes viene accusato di ingiuria per aver apostrofato Pietro, figlio di Bortolo Zambelli, come «Figliol d’un ladro come ti è, ti Pietro, che tuo padre s’ha tachato la borsa alli testicoli» [4]. Nel 1681 è Zambattista de Betto ad essere ingiuriato da Silvestro Manaigo, che lo chiama «figlio d’un becazo [capronaccio], figliol di una putanazza, figlio di quelle razze buserade de zapotti [letteralmente “ciabatte”, in senso lato “incapaci”] di quelli di Betto» [4].
Dagli insulti e le bestemmie si passava spesso alla violenza fisica: l’arma di gran lungo preferita dagli ampezzani erano senz’altro i sassi, che scagliavano con grande precisione contro i loro avversari, ma anche i bastoni erano molto apprezzati. Non era però raro che qualcuno mettesse mano ad un coltello, una “simitera” (scimitarra), un “verduco” (spada a sezione quadrangolare), uno “stillo triangolo” (pugnale a sezione triangolare). Col progresso tecnologico compaiono anche pistole e archibugi, oltre a una “balla zalina” (sfera di ferro), scagliata contro un inerme avversario.
Nessuno si risparmiava: nel 1668 ad azzuffarsi sono due sacerdoti, pre Zuan Menardi e pre Giacomo Zambelli; nel “Processo criminale contro Piero Gidini et altri che betolavan all’Ospedal” [5], intentato nel 1609, è coinvolto addirittura l’allora capocomune d’Ampezzo. Questi viene accusato di aver seguito sulla strada verso casa il signor Tizian del Fauro, con cui si era scontrato verbalmente e fisicamente nell’osteria, e di averlo preso a sassate in testa; il Gidini si difende affermando che l’accusatore «da vino sia cascado aspramente su certi sassi», procurandosi da solo quelle ferite.
In ogni caso, gli scontri fisici e verbali spesso si concludevano in modo non troppo grave: gli omicidi erano rari, e l’esito più comune era qualche ferimento, o un tuffo nel “brento” (fontana), dove un facinoroso finì la vigilia di Natale del 1674. La conseguenza più onerosa per le teste calde era costituita dalle sanzioni, spesso esemplarmente severe, che potevano essere costituite o da una multa pecuniaria, o dalla reclusione al castello a pane acqua, o, nei casi più gravi, dal bando.

Un “brento” in un’incisione di Giulio Siorpaes (1990).
[pgbandion]
NOTE
[1] Tiroler Landesarchiv, Causa Domini 1558, c. 215.
[2] La lingua usata negli atti processuali non è il ladino effettivamente parlato all’epoca, ma un italiano venetizzante usato nei contesti ufficiali.
[3] Tiroler Landesarchiv, Grenzacten 45/7.
[4] Atti processuali conservati nell’Archivio Comunale di Cortina d’Ampezzo, trascritti da Illuminato de Zanna, in Due Soldi, Cortina d’Ampezzo, 1966, 1967, 1968, 1971.
BIBLIOGRAFIA
LORENZI, A., Il Seicento in Ampezzo: statuti, vita, processi e devianze, Venezia, 2013.
RICHEBUONO, G., Storia d’Ampezzo. Studi e documenti dalle origini al 1985, Cortina d’Ampezzo, 1993.
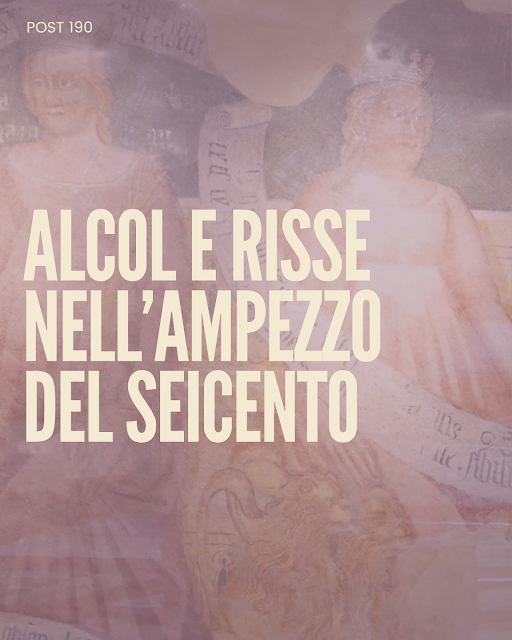
Commenti
Posta un commento